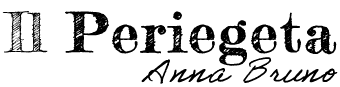È Alexandre, un architetto parigino, il protagonista dell’ultimo film del regista francese, Eugène Green, La Sapienza. Un architetto che persa l’ispirazione, per superare l’angoscia del non riuscire ad afferrarla, si volge all’azione: un viaggio per ripercorrere le tracce di un collega del passato, che con lui sembra avere ben poco a che fare, il Borromini. Alexandre, l’architetto del sociale a confronto con Borromini, l’architetto mistico per eccellenza, l’architetto della Luce.
Un viaggio che da fisico si rivela, fin da subito, essere Viaggio dell’Anima, e che vedrà come traguardo la Sapienza. Lo rivela all’occhio dell’osservatore attento, il giardino ziqurrat dell’Isola Bella, il paradiso delle isole borromee sul Lago Maggiore e che fa da sfondo all’inizio e poi al termine del percorso del nostro protagonista, dei protagonisti! Ma attenzione, la Sapienza, non è erudizione, né indottrinamento. Al contrario! La Sapienza può essere solo se si spoglia di entrambi, affinché la luce trovi vuoto lo spazio per la giusta accoglienza! E il rimando allora continuo è all’Hypnerotomachia Poliphili (o sogno di Polifilo), di Francesco Colonna e all’isola di Citera. Dove il sogno è tensione tra terra e cielo, tra affezioni corporee e sensibili, adombranti la visione, e le aspirazioni dell’anima dischiusa alla conoscenza e alla migrazione verso l’intellegibile.
In questo film-percorso di luce, il suo regista è anche lo sceneggiatore, che parte dal travaglio del foglio bianco e che, una volta macchiato di inchiostro di scene raccontate, queste diventano immagine: percorso di vita del loro stesso ideatore e creatore. Lo si avverte dall’inizio alla fine.
Eppur leggero si presenta il film, nelle scene quanto nei dialoghi, entrambi essenziali, sottesi di forza liberatoria rispetto alla pesantezza dell’erudizione, dell’ombra, dell’inconscio malato. E allora, la leggerezza del film non è superficialità. Essa subentra dopo la fatica e l’impegno del tortuoso percorso verso la Luce. Scene e dialoghi si ripetono come rintocchi di un pendolo, come suoni cantilenati, come fossero rito. E una macchina da presa è fissa e silente su di essi. Perché si sa: è nel viaggio, nel rito e nel silenzio che l’anima ritrova la luce e dunque se stessa. E spesso, poi, le scene si ripetono davanti a una tavola e i personaggi seduti, rigorosamente l’uno di fronte all’altro, paiono trarre ispirazione da i giocatori di carte di Paul Cézanne, dove impera l’architettura e la forma di profumo classicista.
Quanto al protagonista, egli diventa presto quattro protagonisti, e quattro è il numero del divino, che nell’immaginario ebraico è Javhé. Due coppie, quella che per facilità da ora in poi chiameremo anziana, raffigurante l’amore coniugale, che ha perso e ricerca se stesso, per ritrovarsi, e quella più giovane, dell’amore fraterno, che per ritrovarsi deve poter esperire il distacco. Ma ognuno dei personaggi dovrà arrivare prima alla propria verità e toccare personalmente la Luce. Alla fine, la toccheranno e entrambe le coppie si ritroveranno nell’abbraccio amoroso. Ma laddove l’architetto e la moglie ritorneranno a procedere insieme, guardando nella stessa direzione, i fratelli si disgiungeranno, accettando il distacco ed il nuovo viaggio: ad ognuno il proprio. Le due coppie si muovono dunque nelle due direzioni opposte, centripeta e centrifuga, richieste di volta in volta dal percorso vitale e amoroso. Perché l’amore è Luce ed è, e può essere, soltanto quando ha la forza della liberazione!…
La prima tappa del viaggio che la coppia anziana intraprende, è nel luogo natio dell’architetto mistico: Bissone, sul lago di Lugano (anche se girato a Stresa sul Lago Maggiore). E il lago è simbolo femminile dell’approdo e dell’accoglienza, ma anche del mistero e dell’ ignoto: il lago ha in sé il mistero della nascita, ma anche della morte con la sua capacità di risucchiare. Ma acqua e luogo natio sono l’inizio di ogni percorso di vita e quando reiterato, inizio a vita nuova. E la visione dell’acqua parte attraverso le numerose teste del dio Giano, di quel dio bifronte, che presiede agli inizi verso la trasformazione.
L’incontro con i giovani fratelli è essenziale per la coppia anziana. Tanto lei, nella fanciulla, ritroverà il suo istinto materno perduto, a causa della prematura dipartita della loro unica figlia, quanto in lui affiorerà la passione per l’insegnamento accanto al giovane, futuro suo studente di architettura. Ma non sarà un insegnamento da docente, quanto piuttosto da maestro, in un rapporto dialogico col discepolo. E lui stesso imparerà, insegnando.
La ragazza e la donna resteranno nello stesso luogo natio borrominiano e insieme usciranno dal buio dell’ombra verso la salvezza. Mosse ognuna da uno spirito opposto, l’una materno, l’altra di figlia, esse si ritroveranno, dopo un lavoro paziente e perseverante, e saranno pronte all’attesa e all’accoglienza del ritorno, dello sposo l’una e del fratello l’altra: entrambe guarite, ognuna dalla propria malattia. L’uomo e il ragazzo invece si incammineranno verso la seconda e infine la terza tappa del fatidico viaggio. E il numero tre come sempre ritorna, trinitario, di dantesca memoria, anticipato da quel simbolo, su cui la telecamera si affaccia, dei tre cerchi borromei incrociati e subito dopo del pellicano, simbolo del sacrificio materno, posti a decorare la facciata della chiesa torinese.
E Torino è la seconda tappa del nostro protagonista architetto e del suo discepolo. E non una Torino qualsiasi, ma quella di Guarino Guarini, che pur partendo dalla mano libera del Borromini, regredisce, come spesso succede al limite umano, ritorna all’ordine delle rigide geometrie, paghe di asservirsi nuovamente alla regola. E per finire Roma, meta e culla indiscussa dell’arte, dove l’architetto e il suo discepolo scelgono la chiesa di S. Carlino alle quattro fontane. E non a caso. Quelle linee berniniane concave e convesse, di cui la chiesa porta il peso di un dinamismo controllato, si chiudono in un cerchio schiacciato per cominciare la deformazione, facendosi ellisse, punto di partenza di un continuum di trasformazioni. Ma Bernini lì si ferma, quasi avesse avuto paura di andare oltre, di oltrepassare il confine del classicismo e cercare lui stesso la Luce, e una volta trovatala, ad essa abbandonarsi.

E qui Alexandre ritrova se stesso, ci si riconosce, ci si identifica. Il suo status è ancora quello beniniano dell’elisse e l’elisse è ancora cerchio che comincia la deformazione, ma da cui ancora la linea non si libera. Attende la Luce sì, e si fa abbraccio accogliente, ma non trova il coraggio di liberarsi ad Essa. No, decisamente non lo fa la linea berniniana. Bisogna proseguire il viaggio e procedere oltre, verso Borromini e la sua S. Ivo alla Sapienza… la Sapienza appunto. Qui i cherubini scendono e le stelle pure, mentre le linee del pennacchio si liberano e si deformano ancora e ancora, fino a trovare il distacco e dunque la liberazione: il cerchio, meglio l’ellisse si spezza e le linee si allungano verso il cielo e si fanno spirale, per perdersi infine nell’aria all’incontro con la Luce. Come fosse lo scarabocchio di un bambino che cerca e trova la luce della sua mamma.
Il ritorno dei due è assicurato. Laddove però quello di Alexandre è per restare: “Pensavo di essere saggio e artista – dirà – e in fondo l’obiettivo ultimo della vita è l’Amore e la sorgente è la Luce”, quello del discepolo, futuro architetto, sarà per ripartire. E chissà? Potrà un giorno dar vita al suo sogno, il giovane studente, di un’architettura templare universale che vede ognuno pregare e a modo proprio, insieme, nella pluralità? Ai posteri larga sentenza.
Un film per pochi La Sapienza? No, certamente no. Solo accessibile a quanti nella vita han voglia di cercarsi e di trovare la propria essenza… con quel cuore che da pietra torna disponibile a farsi carne.