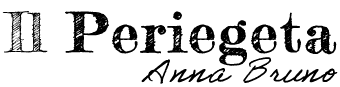L’arte non è solo il racconto del sentire di un’interiorità solipsistica. Non è neanche la sola tecnica utilizzata dall’artista. E neanche il solo suo contesto storico e di gusto. L’arte, di natura acuta e intuitiva, nasce – specie quando è arte di rottura – dall’urgenza di esorcizzare un disagio rispetto a scelte collettive, di cui riesce a percepirne traiettorie e traguardi tossici.
“L’arte è lo svelamento di pezzetti di verità, a seguito di un’intuizione iniziale e di un successivo processo creativo, più o meno lungo, messo in opera dalle sapienti mani dell’uomo, dove per Sapienza si intende quella volontà di fare connessioni e creare equilibrio tra elementi di conoscenza, mentali ed empatici, materiali e spirituali, acquisiti nel tempo. Uno svelamento di valore culturale, estetico, etico, persino di rottura, capace di imprimere un segno nell’immaginario collettivo e in esso farsi memoria, fonte di ispirazione e/o punti di snodo per altri momenti creativi (….)” scrive la sottoscritta nel testo Intorno all’educazione all’arte (dall’eutropia all’eutopia) (Palombi Editori, 2018 pg. 23 https://www.periegeta.it/it/libro-intorno-all-educazione-all-arte/)
In questo senso, l’arte coglie i segni dei tempi e spesso guarda all’ Oltre, facendosi altresì cura per l’animo umano, dove per cura – dal sanscrito ku/kav – si intende osservare con sapienza.

A tal proposito, la preoccupazione dell’informazione, in questi ultimi giorni, è se l’artista Salvatore Garau sia “genio o furbetto?” per essere riuscito a vendere una delle sue sculture invisibili alla lauta somma di 15 mila euro. E al giornalista che gli ha mosso l’obiezione di aver venduto comunque un’opera che non si vede, l’artista sardo ha risposto con semplicità: “si vede col cuore. Le sculture invisibili sono la metafora perfetta dei tempi che stiamo correndo” e, aggiungo io, del dove verso cui ci stiamo dirigendo. In fondo le sue opere mirano a spiazzare quanti attraversano le vie di una qualunque città metropolitana ed il suo trambusto, e non per far sentire il vuoto, quanto l’assenza. Anche se Salvatore Garau non è il primo a metterci di fronte all’assenza dell’oggetto artistico. Il primo a giocare sulla dicotomia presenza-assenza, visibile-invisibile fu l’artista Gino De Dominicis, con la sua opera il Cubo invisibile (1967).
Ma l’assenza di cosa? 
Della nostra capacità stessa di guardare.
Oggi, attraversiamo le città calpestandone i marciapiedi, o allora protetti nell’abitacolo di un’auto privata o di un mezzo pubblico, o ancor peggio su un automizzante monopattino alla moda, sempre assorti nei pensieri della “preoccupazione di”, facendo della città stessa un continuum di oggetti e persone invisibili.
E allora l’artista dell’oggetto artistico assente si chiede: e se fosse l’oggetto artistico a rendersi invisibile? E se infine questi oggetti artistici scegliessero 7 città metropolitane come 7 sono i giorni della creazione, 7 i bracci della menorah, 7 i doni dello Spirito Santo, 7 è il simbolo della totalità e degli spazi per i pitagorici, e ancora 7 le note musicali e 7 i chackra, cosa succederebbe? Le sette statue invisibili diventerebbero metafora di ciò che non riusciamo più a vedere, perché non sappiamo più guardare e restare a con-templare. Va da sé che diventa difficile poter creare, tanto meno curare l’Arte e la Natura da cui l’arte si ispira. E questo, nonostante l’arte continui a vedere oltre l’assenza del nostro guardare, l’anestetizzazione delle nostre emozioni a causa dell’annosa educazione astraente, e dunque a causa dell’astrazione. Quella stessa astrazione propostaci proprio dall’arte agli inizi del ‘900, che, bontà sua, precorse i tempi umani, nel cammino verso il distacco dalla natura, dalla campagna, dalla terra, che si fecero pian piano puro elemento di arredo. Pura astrazione. Null’altro. E astratti divennero anche parole e pensieri, volti e incontri, interiorità e rapporto con la Natura e con i propri simili, con l’arte e la vita quotidiana, e con i loro significati valoriali.
 Da qui la provocazione dell’artista sardo: se di astrazione ci nutriamo quotidianamente, proviamo a vendere quest’astrazione, vendiamo l’assenza. A cosa serve la materia se non possiede più vita interiore, se non ha più alcun significato archetipico, se non è più essenza, autenticità, memoria? Se all’uomo la materia non serve più vuol dire che essa non potrà più corrispondere al vero, né al buono, né al bene comune, dunque neanche al bello. L’oggetto è in quanto è bene di consumo? Ma noi siamo già nel tempo in cui abbiamo consumato tutto (il Creato del buon Dio?): oggetti, animali, prodotti della terra, acqua, aria, gli stessi uomini e la loro prole. Non rimane altro che assenza: vendiamola dunque! E alla fine, spiazzando gente comune e profitto, le 7 opere invisibili di Garau, in quelle città metropolitane, avranno al contrario il potere dell’illuminazione, saranno un’assenza che richiama alla presenza, totale.
Da qui la provocazione dell’artista sardo: se di astrazione ci nutriamo quotidianamente, proviamo a vendere quest’astrazione, vendiamo l’assenza. A cosa serve la materia se non possiede più vita interiore, se non ha più alcun significato archetipico, se non è più essenza, autenticità, memoria? Se all’uomo la materia non serve più vuol dire che essa non potrà più corrispondere al vero, né al buono, né al bene comune, dunque neanche al bello. L’oggetto è in quanto è bene di consumo? Ma noi siamo già nel tempo in cui abbiamo consumato tutto (il Creato del buon Dio?): oggetti, animali, prodotti della terra, acqua, aria, gli stessi uomini e la loro prole. Non rimane altro che assenza: vendiamola dunque! E alla fine, spiazzando gente comune e profitto, le 7 opere invisibili di Garau, in quelle città metropolitane, avranno al contrario il potere dell’illuminazione, saranno un’assenza che richiama alla presenza, totale.
Dunque, come è possibile uscire da quest’impasse o sindrome da assenza?

Disimparando! Disimparando ciò che si è assunto come iconico dall’ ‘800 in poi. Ricreando assenze per ricostruire presenze. Ripulendo pensieri, parole, significati, energie: liberandoci di ciò che riteniamo non più discutibile e che non tocca più l’anima, lasciandola nella confusione.
E se al contempo l’arte cominciasse ad uscire, essa stessa, dai gangli coercitivi del mercato, vuol dire che sarà già in grado di riprendere in mano le redini della sua più grande missione: quella di curare ed educare, di fornire idee nuove e nuovi significati, di aprire gli occhi sulla visione del mondo e del proprio sé, personale e collettivo. Perché il pensiero torni ad essere connettivo, creativo, speculativo, torni ad essere il pensiero dell’ Oltre, in modo che gli oggetti artistici possano ritornare ad animarsi e a farsi visione su concetti che abbiano valore profondo per la crescita e l’armonia dell’animo umano, segni sacri, alla stessa stregua dei geroglifici. Oggetti artistici che si propongano come orma, memoria, presente e futuro, disponibili alla trasformazione.
Ma ancora, come faremo a cogliere facilmente quei concetti?

Attraverso lo svuotamento degli attuali contenuti della mente, dei pre-concetti, dei pre-giudizi (diversi dai giudizi analitici, previa conoscenza), dei pensieri pre-confezionati, spesso rigidi e negativizzanti, per tornare a con-templare l’arte e se stessi (stare con il proprio tempio, o con il tempio dell’arte) e poter giungere pronti alla meditazione.

Il termine meditare, dalla radice indoeuropea ma- (man-), contiene il doppio senso di misurare e di pensare (similmente a medico e a mente): misurare con la mente e volgere nell’Animo. Meditare insomma è ripensare a lungo, riflettere, e riflettere vuol dire imparare a discernere, eliminando ciò che non serve, per giungere ricchi di buoni contenuti e liberi da quelli dannosi davanti all’osservazione sapiente e al potere delle connessioni, affinché il pensiero si mantenga duttile per il rinnovamento.
Nei tempi antichi, attraverso l’arte – ogni tipo di arte – si trasmettevano insegnamenti che risvegliavano, in chi li riceveva, quell’impulso-memoria di essere parte infinitesimale di un tutto chiamato Universo. Oggi sembra che l’arte abbia voglia di tornare ad investire sulle leggi superiori e a rivelare a noi quelle parti della nostra stessa interiorità che altrimenti rimarrebbero represse per sempre e ad aiutarci a superare quella serie di barriere difensive innalzate nel tempo ma che frenano il decollo della nostra sensibilità creativa. E se davvero le cose stanno così, se davvero l’arte è ciò che ci lascia intuire oggi, non ci resta che fermarci davanti ad essa e imparare ad osservarla e con pazienza ascoltare le sue innumerevoli voci silenti dell’Oltre. Solo così sarebbe possibile poterla seguire davvero, partecipando. E insieme ad essa modificare in bene e in anticipo il corso degli eventi in un corso di senso, perché nel frattempo avremo imparato a guardarci dentro e a modificare noi stessi in nome di un mondo migliore, di senso comune.